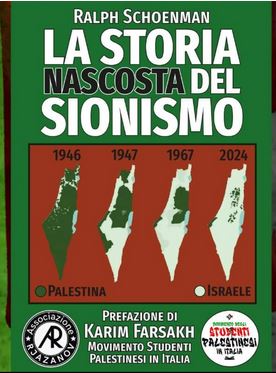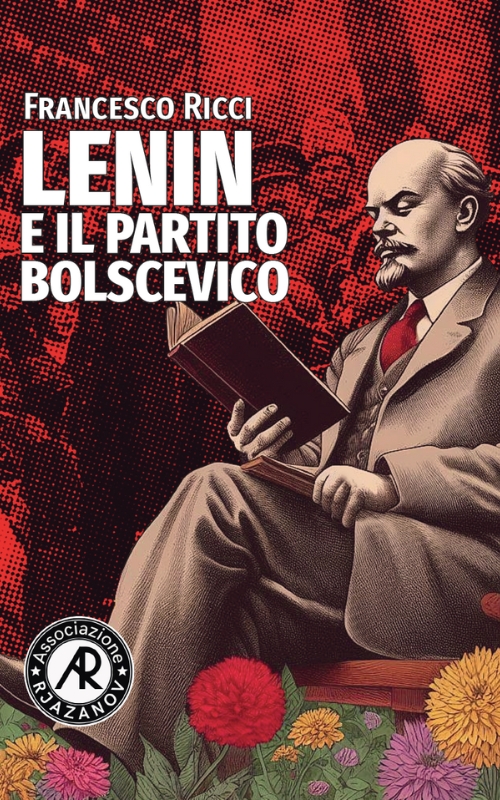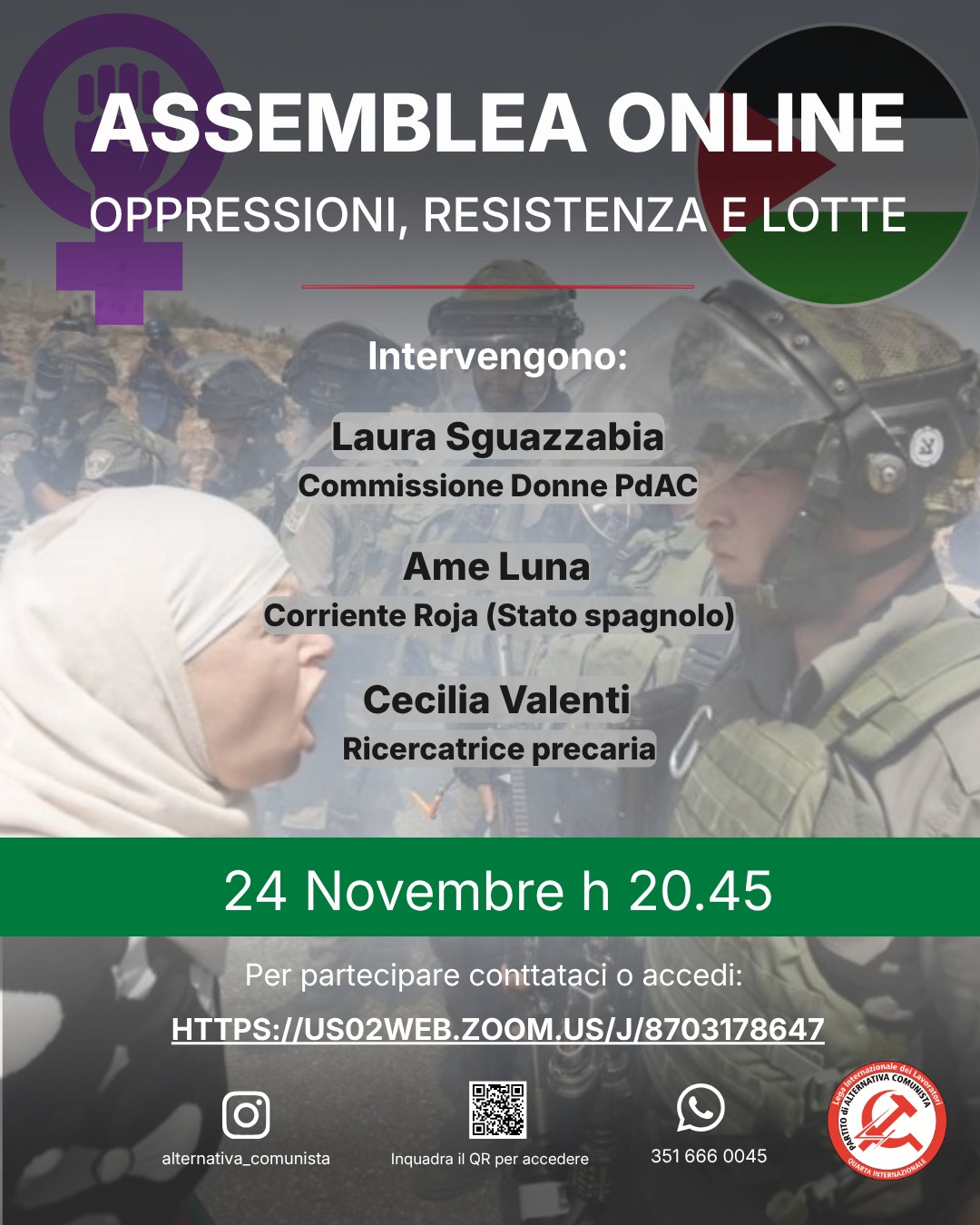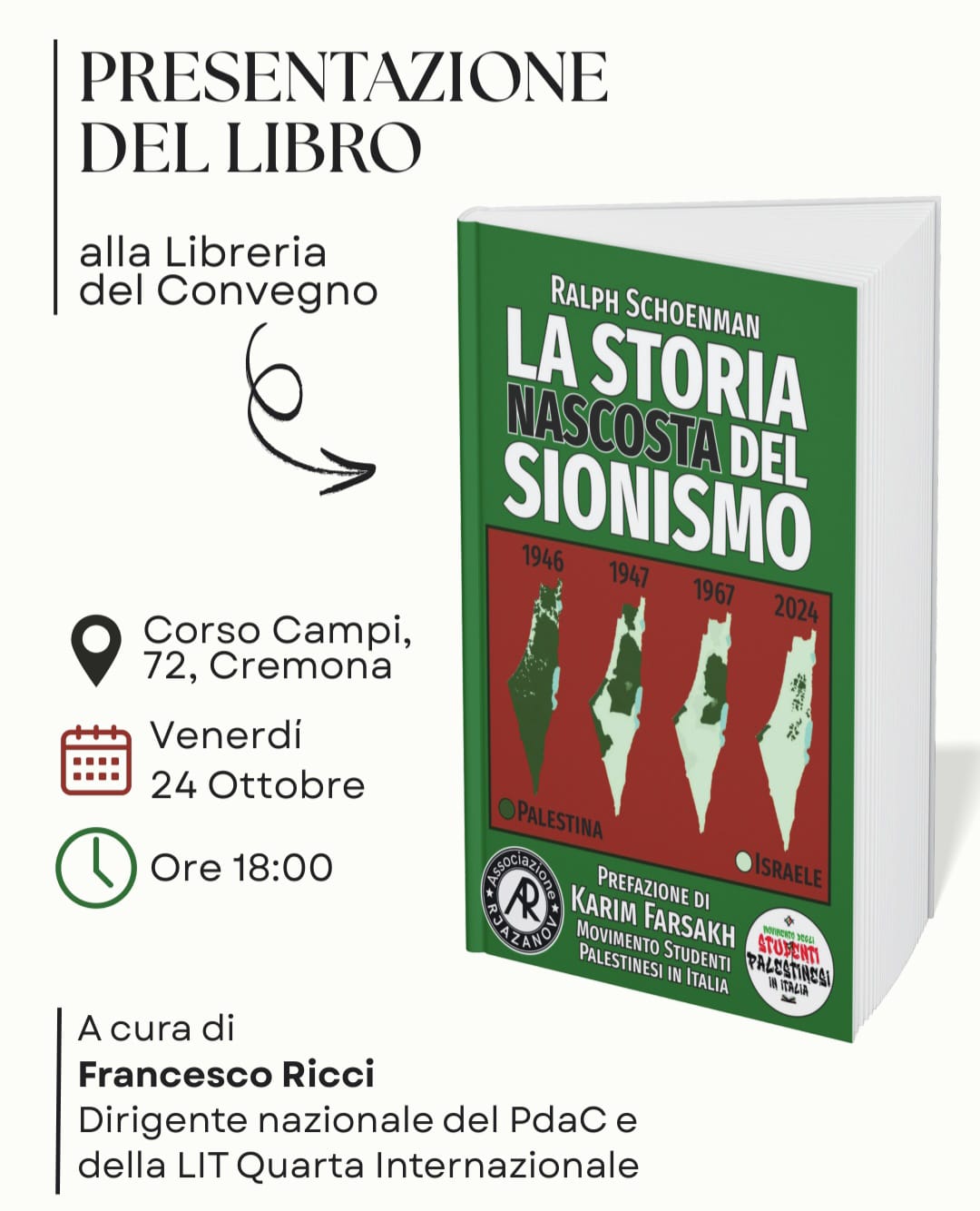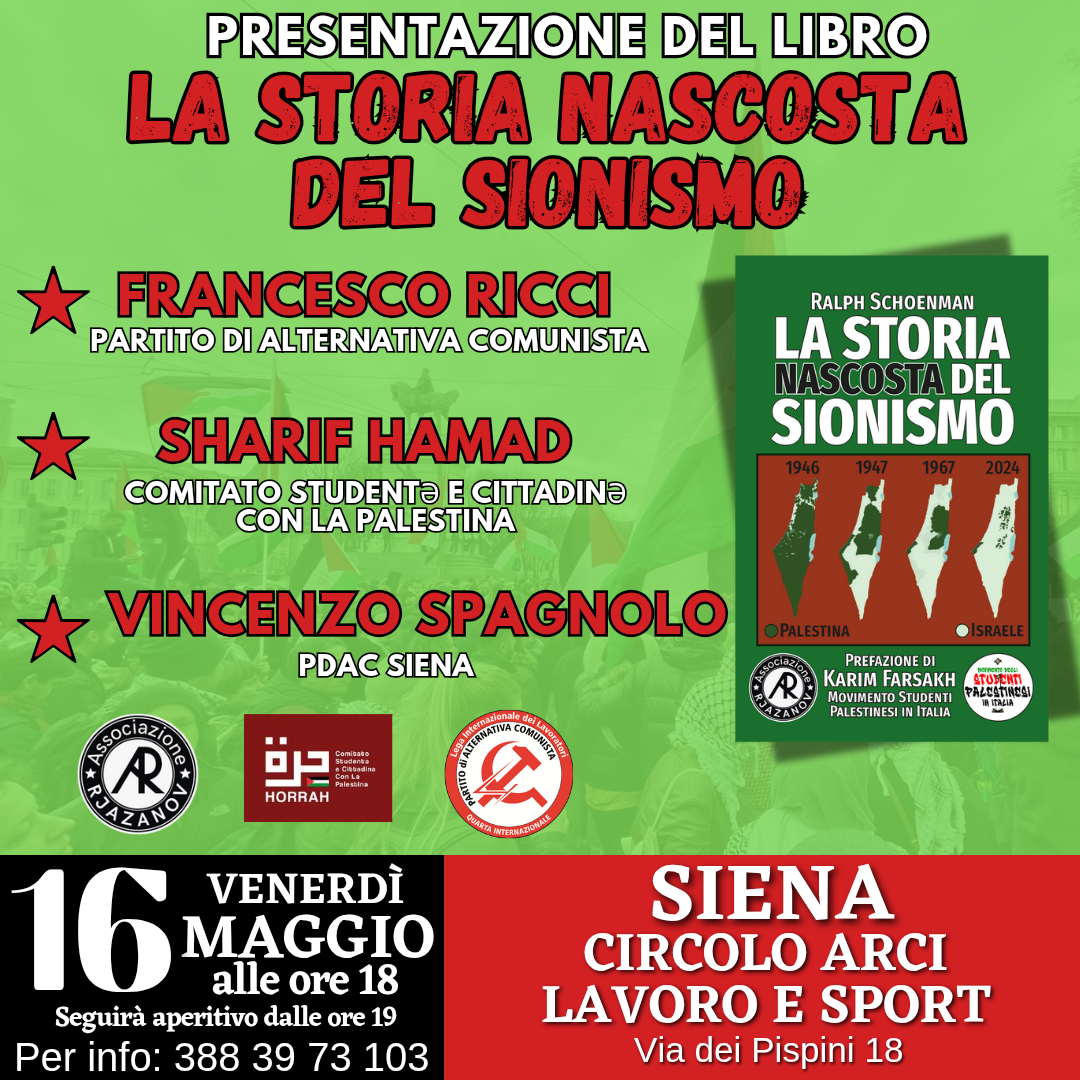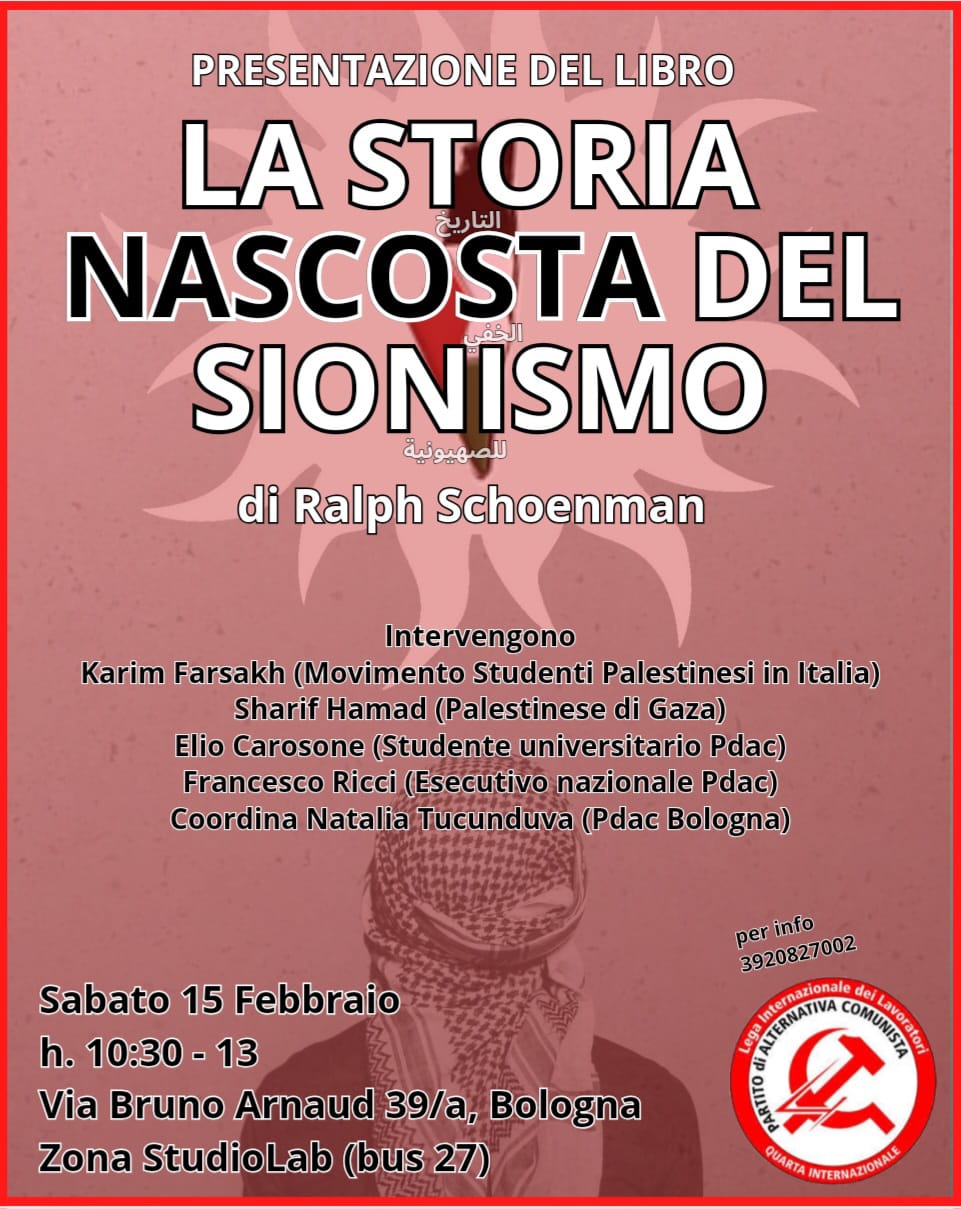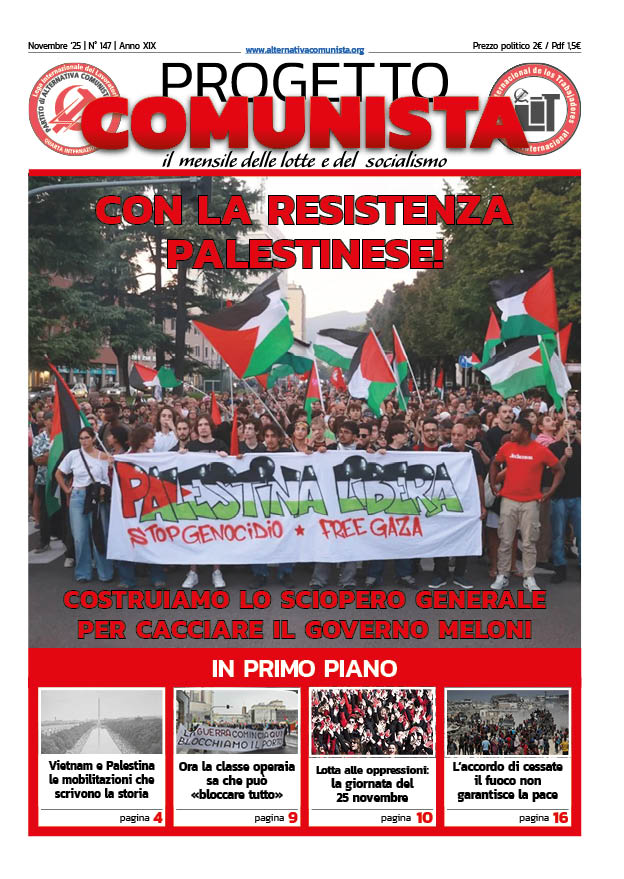Rifondazione e l'eterno dilemma:
indipendenza di classe o compromesso con la borghesia?
di Francesco Ricci

Prima di esprimere la nostra opinione sul Congresso di Rifondazione conclusosi nei giorni scorsi, vorremmo premettere che nutriamo rispetto per i militanti di quel partito e per il loro travaglio. Anche se ci dividono strategia e tattica, ci unisce la volontà di lotta contro un mondo marcio che tutti vorremmo cambiare.
Chi scrive queste righe è stato per i primi quindici anni di vita del Prc militante e dirigente di quel partito, dando insieme ad altri una battaglia contro i vari gruppi dirigenti (Cossutta-Garavini, Cossutta-Bertinotti, Bertinotti-Ferrero) succedutisi tra il 1991 e il 2006, anno in cui demmo vita alla prima delle quattro scissioni dei gruppi che si richiamavano al trotskismo che avevano fatto parte di Rifondazione (per quanto ci riguarda, sempre in opposizione alla linea maggioritaria).
Quei primi quindici anni, così come gli ulteriori venti, hanno sempre visto Rifondazione dibattere, in fin dei conti, di un'unica questione: essere l'ala sinistra, il preteso «pungolo», dello schieramento di centrosinistra o costruirsi come alternativa di classe alla cosiddetta borghesia «progressista» (ieri Prodi, oggi Schlein) e ai suoi governi e giunte?
Ora, per quanto possa sembrare strano, se si fa eccezione per alcune delle scissioni «di sinistra» (la nostra e altre), tutte le principali spaccature di Rifondazione, pur essendo avvenute sempre inderogabilmente sul tema ora menzionato, non hanno mai visto un settore del gruppo dirigente rompere con la collaborazione di classe per imboccare una prospettiva di indipendenza di classe.
La forza distruttiva della collaborazione di classe
Chi ha vissuto dall’interno o studiato la storia di Rifondazione può constatare una cosa: le rotture di quel partito (ripetiamo, ad eccezione di quelle di alcune componenti di sinistra) hanno sempre visto una contrapposizione su tempi e modi dell'accordo col centrosinistra borghese e i suoi governi. Mai nessuno dei gruppi dirigenti in cui si è via via rotta la maggioranza del partito ha proposto di imboccare un'altra via, mai nessuno ha indicato come malattia di Rifondazione, sin dalla nascita, la rimozione dell'indipendenza di classe dalla borghesia e dai suoi governi.
Eppure è proprio questo il tema che da due secoli ha prodotto la maggior parte delle divisioni nel movimento operaio. Sugli scogli della collaborazione di classe si ruppe la Seconda Internazionale; contro quegli stessi scogli, evitati solo per pochi anni dai comunisti guidati da Lenin e Trotsky (che riaffermarono l'opposizione di classe a qualsiasi governo nel capitalismo come un principio marxista irrinunciabile), lo stalinismo fece schiantare tutte le rivoluzioni del Novecento.
Ma, come dicevamo, le rotture della maggioranza dirigente di Rifondazione, pur riguardando la risposta da dare a questo problema fondamentale, scegliendo tra la risposta di Lenin e Trotsky (l'indipendenza e l'opposizione di classe) e quella di Stalin, Togliatti e Berlinguer (i «fronti popolari» e il «compromesso» con la borghesia), hanno sempre visto entrambi i settori in scontro scegliere la via della collaborazione di classe, dividendosi appunto solo sul come percorrere quella strada, non sul se farlo.
Limitiamoci a guardare rapidamente alle rotture maggiori di Rifondazione. Il primo scontro fu quello tra Cossutta e Garavini (1992-1993) e aveva per tema «l'unità d'azione» con il Pds. Poi fu la volta (1995) della scissione del Movimento dei Comunisti Unitari (Magri e Crucianelli) che ruppero con Cossutta per sostenere il governo Dini. Poi arrivò la scissione (1998) di Cossutta e Rizzo con Bertinotti per sostenere il governo Prodi 1. Iniziò qui la fase del cosiddetto «ritorno a Marx» di Bertinotti, formula dietro cui si nascondeva la lunga marcia per riguadagnare l'ingresso nel governo borghese. Alla testa di questo movimento, e a fianco di Bertinotti, c'era Paolo Ferrero (che precedentemente era stato più o meno in minoranza). Il riavvicinamento al governo borghese, grazie anche alla strumentalizzazione del movimento no global, sfocerà quindi nell'ingresso nel secondo governo Prodi, con Ferrero ministro della «Solidarietà sociale» (sic) di questo governo imperialista, e vari sottosegretari al seguito.
Era il coronamento di una lunga marcia che, ripetiamolo, aveva visto molti scontri nei gruppi dirigenti di maggioranza, ma mai uno scontro reale sulla strategia.
E siamo allo scontro tra Vendola, Migliore e i bertinottiani da una parte e Ferrero (2008). Nel Congresso di quell'anno Ferrero venne eletto segretario (con uno scarto di 2 voti) col sostegno delle aree di provenienza stalinista (Grassi, Giannini) e con quello di Bellotti e di Falcemartello (poi Scr, ora Pcr) che contribuì ad accreditare una inesistente «svolta». Anche qui la rottura riguardava il tema del rapporto col centrosinistra borghese ma nessuna delle due ali della ex maggioranza sosteneva una reale discontinuità con la lunga stagione della subalternità ai governi borghesi. Per questo l'ala «sinistra» della rottura (Ferrero) mantenne e incrementò tutte le alleanze a livello locale col Pd (a livello nazionale Rifondazione aveva ormai poco da offrire al centrosinistra). È l'ora dell'alleanza «anticapitalista» (la Federazione della sinistra) di Rifondazione con gli ex ministri di governi imperialisti Diliberto e Cesare Salvi (già ministro del lavoro in un governo Amato...).
Finita anche quest'esperienza, fu l'ora del «fronte democratico per battere Berlusconi», basato su un'alleanza nel Prc tra Ferrero e Claudio Grassi (che poi uscirà per ricongiungersi con Fratoianni e Sel, e in seguito diventare l'organizzatore della fallimentare lista Santoro).
Inizia così un periodo in cui il gruppo dirigente di Rifondazione cerca di recuperare voti (e parlamentari) da poter spendere per essere credibile nella trattativa di governo con il Pd. Di qui vari tentativi elettoralistici e il celare il simbolo presentandosi in alleanza con settori ultra-moderati, inclusa l'Italia dei Valori di Di Pietro: è la breve e fallimentare esperienza di «Rivoluzione civile» con la candidatura dell'ex magistrato Ingroia.
Siamo al 2014, quando Rifondazione presenta la «lista Tsipras» alle europee, indicando nel leader di Syriza il proprio modello di «sinistra». Di lì a poco (2015) Tsipras, investendo il capitale accumulato nella fase in cui si presentava come alternativa, sarà premier in Grecia, applicando la politica «lacrime e sangue» voluta dall'imperialismo europeo.
Nel 2017 è l'ora della costruzione della «sinistra anti-liberista» con... Bersani, Civati e Sinistra Italiana. Acerbo viene proposto da Ferrero come nuovo segretario per portare avanti questa «nuova» linea.
Il passaggio successivo fu la lista elettorale di Potere al Popolo, che pure avrà vita breve (da qui nascerà il partito Pap, attorno alla Rete dei Comunisti-Usb). Poi altri infiniti (ne saltiamo alcuni per brevità) tentativi di sommatorie elettorali per cercare di rientrare in parlamento o nei Consigli locali, fino all'ultima fallimentare lista con Santoro alle europee del 2024, ancora una volta nascondendo il simbolo del partito e attorno a un programma a dir poco moderato.
In ognuno di questi passaggi si sono determinati scontri nel gruppo dirigente, sempre sul tema delle «alleanze». Ma, significativamente, così come è stato per tutta la storia di Rifondazione, non si è mai trattato di differenze realmente strategiche. Lo scontro è sempre avvenuto esclusivamente sul come portare Rifondazione all'accordo con un settore borghese. Così è stato anche nel recente congresso conclusosi nei giorni scorsi, di cui ci occuperemo tra poco.
Il piano inclinato verso il Pd borghese
Fin dalla sua nascita, a causa del suo programma – che non è mai stato un programma comunista, al di là delle intenzioni soggettive di migliaia di militanti – Rifondazione è stata collocata su un piano inclinato. Per questo ha continuato a scivolare verso il basso e via via una maggioranza dei suoi dirigenti di maggioranza ha rotto col partito per meglio integrarsi negli apparati borghesi.
Per fare solo qualche esempio tra i più noti: Bertinotti, il più famoso tra i dirigenti (Rifondazione veniva identificata col suo nome), è finito col fare dichiarazioni sulla «morte del comunismo» per pietire un qualche spazio sui media o un invito alla festa di Comunione e Liberazione; Gennaro Migliore, candidato delfino di Bertinotti, fa oggi il portaborse di Renzi; Fratoianni e De Cristofaro, tra i principali dirigenti dei Giovani Comunisti nel periodo di massima espansione di questa struttura (oggi ridotta al 6% del partito), dirigono Sinistra Italiana, struttura di servizio del Pd della Schlein. Altri hanno trovato ottime collocazioni personali: come Michele De Palma, altro dirigente dei Giovani Comunisti, oggi segretario generale di una Fiom che ha abbandonato anche l'immagine della combattività. La lista potrebbe continuare a lungo: sottosegretari, deputati, senatori eccetera. Tutti i dirigenti di maggioranza hanno prima o poi avuto la loro poltrona o poltroncina, rivelando che – come diceva il grande dirigente trotskista statunitense James Cannon – ciò che divide i comunisti dai dirigenti riformisti non sono diverse concezioni ideologiche: ma diversi interessi di classe.
L'ultimo Congresso: la natura dello scontro tra Acerbo e Ferrero
Arriviamo ora all'ultimo Congresso, conclusosi pochi giorni fa a Chianciano con la riconferma di Maurizio Acerbo come segretario nazionale.
L'area di Acerbo ha prevalso su quella di Ferrero per una manciata di voti (contestati dalla «minoranza»).
Lo scontro Congressuale, come si può vedere leggendo i testi del dibattito ma anche guardando la diretta video da Chianciano, è stato durissimo, quasi da resa dei conti finale. In una semplificazione ricorrente la divisione è stata presentata come tra fautori delle alleanze ad ogni costo (Acerbo) e sostenitori di un polo alternativo (Ferrero). In realtà ancora una volta lo scontro tra le due ali del gruppo dirigente non è strategico.
Nessuna delle due posizioni propone, facendo tesoro di un quarto di secolo di esperienza di Rifondazione (e di altri due secoli di storia del movimento operaio), di rompere definitivamente con la collaborazione di classe con la cosiddetta borghesia progressista e i suoi governi nazionali e locali. L'unica reale divisione riguarda, ancora una volta, non il dove andare ma il come arrivarci.
In sintesi: Acerbo (qualche anno fa presentato da Ferrero come suo sostituto alla segreteria) punta a un accordo diretto col centrosinistra della Schlein (valutando tra l'altro che il Pd sarebbe in parte cambiato). Ferrero, anche consapevole dello scarso potere contrattuale della Rifondazione attuale, propone invece di usare il prossimo periodo per rafforzare una relazione con altri settori (Pap e quanti facevano parte di Unione Popolare, rottasi attorno alla lista per le europee) e aggregare forza critica nelle lotte e movimenti per poi arrivare con questo «terzo polo» - transitorio – e, attraverso una marcia più lunga con un qualche peso contrattuale, alla trattativa col centrosinistra; senza escludere nel frattempo accordi di governo locale col centrosinistra, dove esso è disponibile. Peraltro che Ferrero (ricordiamolo ancora: ex ministro di un governo imperialista) non sia ostile alle alleanze con la borghesia lo dimostra come in Sardegna la sua componente abbia stretto per le ultime regionali un accordo a sostegno di Soru in compagnia di due campioni delle lotte... anti-operaie, come Calenda e la Bonino.
Lo scontro è allora, insistiamo, su quale via imboccare per raggiungere la stessa meta: il sostegno (interno o esterno, Rifondazione li ha provati entrambi) a un governo dell'imperialismo italiano. La stessa identica meta perseguita da un quarto di secolo da tutti i gruppi dirigenti di Rifondazione. Quella meta che ha portato Rifondazione a essere una versione in sedicesimo (letteralmente) di quanto era all'inizio, alla delusione e dispersione di energie militanti. E che soprattutto ha portato all'approvazione – senza opposizione – delle peggiori politiche anti-operaie. Il che spiega perché la grande borghesia a suo tempo (quando Rifondazione aveva un certo peso nella classe) è sempre stata favorevole a includere Rifondazione nelle maggioranze di governo e certo non si è mai spaventata per il presunto «condizionamento a sinistra» che i vari Bertinotti e Ferrero promettevano ai militanti.
A partire da differenze puramente tattiche tra Acerbo e Ferrero, si sono poi accumulati nell'ultimo periodo contrasti e frizioni anche personali nel gruppo dirigente, alimentati anche dai continui fallimenti di tutti i tentativi di rientrare in parlamento. Per presentare con una veste dignitosa quello che è nei fatti uno scontro tra due settori della medesima burocrazia dirigente, ognuna delle due parti ricorre poi ad elementi «identitari». Acerbo, coerentemente con la sua posizione, sta riscoprendo tutti i «padri nobili» del compromesso con la borghesia: di qui i continui richiami a un comunismo «democratico», a Tortorella e Ingrao, eccetera. Mentre Ferrero strizza l'occhio allo stalinismo «campista» (vedi le sue vergognose dichiarazioni sulla Resistenza ucraina all'aggressione imperialista di Putin).
Per il momento, in mancanza di altre possibilità, il Congresso si è concluso con un patto da separati in casa e col rinviare a un referendum interno la scelta rispetto alle prossime elezioni.
Per la rifondazione di un vero partito comunista
Se qualcosa insegna la storia degli ultimi due secoli è che la lotta di classe è inevitabile in una società divisa in classi, in cui si contrappongono interessi inconciliabili: quelli di padroni e lavoratori, detentori dei mezzi di produzione e di scambio e salariati, borghesi e proletari, per usare i termini attualissimi di Marx. Questa lotta – apprendiamo se studiamo la storia, anche la più recente – tende periodicamente ad acuirsi. La forma più acuta della lotta di classe sono le rivoluzioni. Ma la storia ci insegna anche che, purtroppo, nessuna lotta, incluse le forme più acute, di per sé è sufficiente per cambiare la società. Per elevare la lotta e perché sia vincente, è necessario costruire nelle lotte un partito operaio e comunista che raggruppi i settori più avanzati (l'avanguardia), in grado di trascinare con sé settori più ampi fino alla conquista del potere da parte della classe operaia, che non può che avvenire per via rivoluzionaria.
Questo ci hanno insegnato, coi loro testi e tutta la loro vita e opera, Marx e Lenin. E questo ci ha confermato tutta la storia, senza eccezioni.
Ora, è evidente, almeno a noi, che quel partito rivoluzionario che è necessario per assolvere a questa opera gigantesca (la più grande che l'umanità si sia mai posta) non esiste, va costruito internazionalmente e in Italia.
Si tratta di un processo difficile e non breve e non sarà risolto da qualche appello. Ma ciò che è certo – almeno per noi e per quanto abbiamo appreso dai nostri maestri, da Marx in poi – è che questo percorso non prevede tappe intermedie in collaborazione di classe, non prevede partecipazioni a governi o giunte borghesi. Viceversa richiede la costruzione di un percorso strategico di indipendenza di classe, di contrapposizione alla borghesia e di smascheramento delle illusioni riformiste seminate a piene mani da burocrazie piccole e grandi.
È a questo obiettivo che lavoriamo come Pdac e con i compagni e le compagne della nostra Internazionale in tante parti del mondo. Non pretendiamo di avere l'esclusiva: al contrario, crediamo che questo progetto non sarà realizzabile senza l'apporto di tanti compagni e tante compagne che oggi militano in altre organizzazioni. E, in Italia, ciò significa rivolgersi anche ai compagni e alle compagne che militano o hanno militato in Rifondazione. A loro, con il rispetto dovuto a chiunque sacrifichi una parte importante della sua vita a cercare di cambiare il mondo, è rivolto questo articolo e l'invito a rifiutare i vicoli ciechi riproposti tanto da Acerbo come da Ferrero. Non abbiamo certo la pretesa di convincere nessuno con un articolo: ma una riflessione approfondita sulla traiettoria di venticinque anni di Rifondazione e dei suoi gruppi dirigenti si impone a ogni militante.
(14 febbraio 2025)